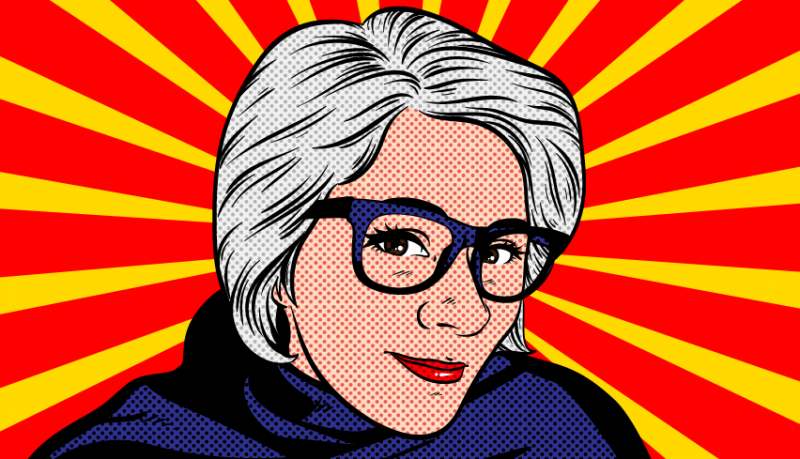Il concetto di “smerdarsi” mi fu spiegato molti anni fa da un collega, Fabio, che lavorava con me nella New Economy.
Facevamo email marketing e io passavo le mie giornate a scrivere e impaginare (sul web) newsletter per i nostri clienti.
Mi facevo un culo bestiale, mentre una stronza che non sapeva neanche NAVIGARE sul web, ed era la STRATEGIST della nostra start up, riusciva a darmi la colpa dei piccoli incidenti di percorso che ti possono capitare se mandi una newsletter a cinquantamila persone alla volta, dopo essertela taggata da sola con un primitivo editor HTML.
La stronza era così abile da farsi passare SEMPRE come protagonista delle attività – fatte da me e dai mie colleghi – che andavano bene, ed era altrettanto abile a spostare la MERDA sulla scrivania di un altro, se per caso qualcosa era andato storto.
Fu appunto Fabio che mi spiegò che la stronza sapeva smerdarsi, ovvero sapeva come passare la merda a qualcun’altro, se per caso le finiva in mano una profumatissima cacca, di quelle che chiunque può produrre quando lavora.
Si possono fare errori – quando si lavora – tutti li fanno.
Ma saperli riconoscere e soprattutto riconoscerli come propri è il primo passo per riuscire a farne di meno.
Se la tua unica strategia è invece quella di smerdarti, alla fine il rischio è di finire seppellito sotto QUINTALI di merda.
La stronza finta-strategist venne infatti licenziata, mentre io rimasi a scrivere le newsletter.
L’operativo – lo smanettone – alla fine si salva sempre, perché qualcuno le cose le deve fare.
Spostare invece sui tavoli degli altri le CACCHE è una strategia di breve periodo.
Ti può andare bene per un po’, ma poi alla fine non ce la fai più.
Se non provvedi infatti a eliminare la fonte di produzione coprofilica, non ti basteranno una dozzina di MOSE per impedire gli tsunami di merda in arrivo.
Ma a quanto pare – mentre l’onda di merda continua a crescere – nessuno fa nulla, se non appunto cercare scrivanie libere sulle quali appoggiare escrementi.
Credo che le cacche di Altan siano la più veritiera descrizione antropologica della nostra classe politica, da noi votata con amore.
Nei secoli fedeli (alla merda).